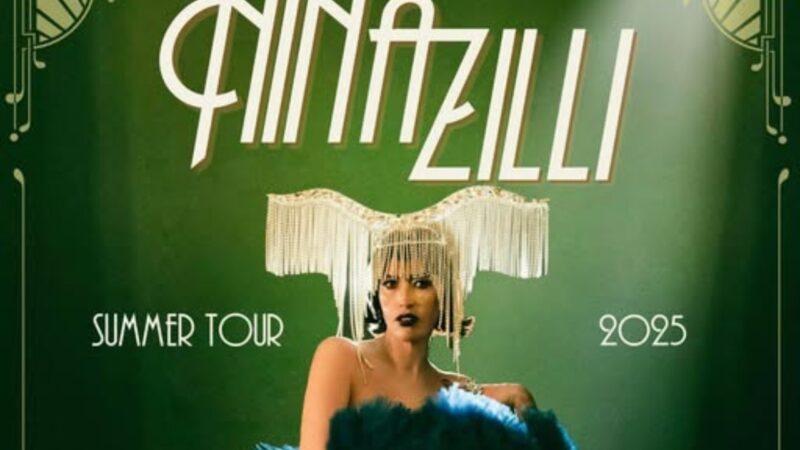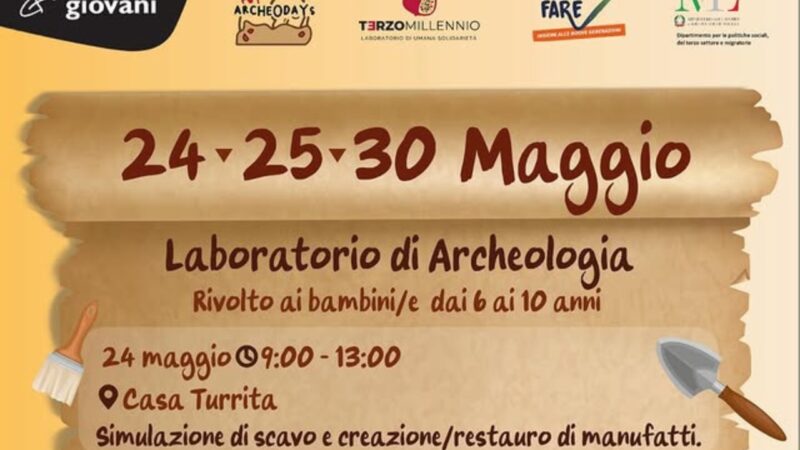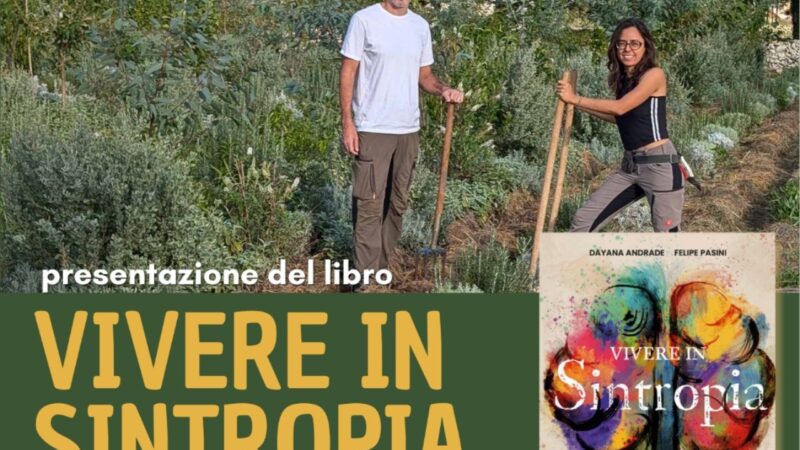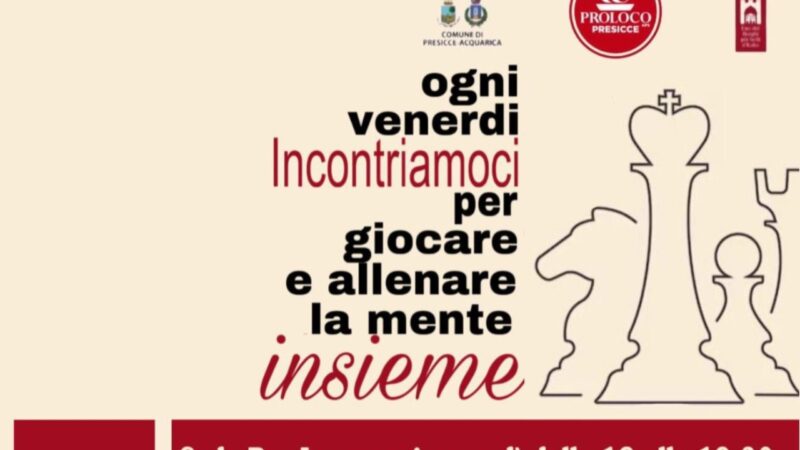Chiesa di San Carlo Borromeo ad Acquarica

La chiesa di San Carlo, che sorge nell’omonima piazza, di fronte al castello, fu edificata nel XVII secolo da Fabrizio Guarino Junior a seguito di un miracolo tramandato da Mons. De Rossi nella relazione della visita pastorale alla Diocesi di Ugento del 1711. Il barone si ammalò e nonostante le sue ricchezze, non riuscì a ingaggiare dei medici con competenze tali da guarirlo; così chiese l’intercessione di San Carlo Borromeo, facendo voto di edificare una chiesa in suo onore: la febbre svanì immediatamente e il barone, ormai guarito, fece costruire la chiesa innanzi al suo castello.
La chiesa fu la prima in Terra d’Otranto e comunque una delle prime nel Regno intitolate a San Carlo Borromeo. Infatti, lo stesso fu canonizzato nel 1610 e la parrocchiale fu istituita nel 1619 (sostituendo quella di San Giovanni).
La sobria facciata è impreziosita da un bel portale, incorniciato da una decorazione di foglie d’acanto e sormontato da un architrave con motivi floreali. Sotto la trabeazione si legge il passo in latino “Qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam salvabitur A.N.D. 1661”: la data probabilmente si riferisce agli interventi di ricostruzione del presbiterio, danneggiato dal crollo del campanile avvenuto pochi anni dopo l’ultimazione.
Il portale è sovrastato da un timpano spezzato con al centro il monogramma JHS; più in alto si trova una grande finestra ovale con grate.
Il campanile ha una linea essenziale, ma la sommità che lo chiude è di stile barocco: due linee curve si ripetono, una volta incavando la figura, poi rigonfiandola e incavandola nuovamente, per poi culminare con una sfera, oggi purtroppo non presente.
Fino agli inizi degli anni Sessanta, come testimoniano alcune cartoline, accanto alla facciata, vi era l’antica torre dell’orologio; tra i suoi ruderi fu trovata l’epigrafe in latino del 1772 che è stata collocata all’esterno del muro di levante e che recita tradotta “I tempi che passano qui vengono segnati e le ore che la pallida morte miete veloce all’uomo. Anno della Redenzione 1772”.
All’interno la chiesa ha una doppia navata: non è noto se quella destra sia coeva a quella sinistra ovvero sia frutto di un rimaneggiamento successivo. Sicuramente essa è almeno del 1664, anno in cui fu costruito l’altare dedicato all’Annunciazione di Maria, ivi collocato.
La navata sinistra, più grande, è a tre campate e presenta sul presbiterio l’altare maggiore lapideo, che purtroppo, a seguito di interventi, ha perduto la cromia originale e che porta ai suoi lati gli stemmi dell’università, presenti anche sull’organo e sul pulpito in legno. La balaustra originale, rimossa a seguito del Concilio Vaticano II, come spesso è accaduto anche altrove, è oggi conservata nella sagrestia.
Sul lato sinistro della navata grande vi sono tre altari: il primo, dedicato alla Madonna del Rosario, del XVIII secolo, custodisce una tela del ‘600, della scuola del Catalano; il secondo dedicato al patrono San Carlo, del XVII secolo, molto ricco, in stile barocco, rappresenta bene la tecnica artistica e la sensibilità cromatica del tempo; il terzo dedicato alla Vergine Immacolata, della fine del XVIII secolo, si caratterizza per le linee rococò e accoglie tre statue lapidee policrome, dell’Immacolata e dei santi Pietro e Paolo, provenienti da un altare preesistente, attribuibili a Placido Buffelli.
Nella navata destra, un tempo vi erano tre altari: quello dedicato alla Madonna di Costantinopoli, quello dedicato alla Madonna del Carmine (oggi perduti) e quello dedicato all’Annunciazione.
Il primo è andato perduto a seguito dei lavori di restauro negli anni ’50; il secondo, del ‘700, conserva la pala e alcune porzioni di stucchi.
Quello dedicato all’Annunciazione, voluto da Giovanni Antonio de Capo, nel 1664, invece, è collocato nella terza campata. Con annessa la tomba di famiglia, esso spicca per l’esuberante modellato barocco, caratterizzato da colonne tortili, finemente decorate: la cromia originale risulta in parte coperta ma superstite, segno del fatto che sicuramente anche esso, come gli altri altari della chiesa, era riccamente policromo. Di pregio diversi manufatti all’interno dell’edificio religioso: fra i vari, quello del Patrono e quello raffigurante l’Immacolata, lignei e di probabile importazione napoletana, testimonianza del vivace rapporto fra il patriziato locale e la Capitale e quello della Madonna del Rosario, di probabile fattura salentina.